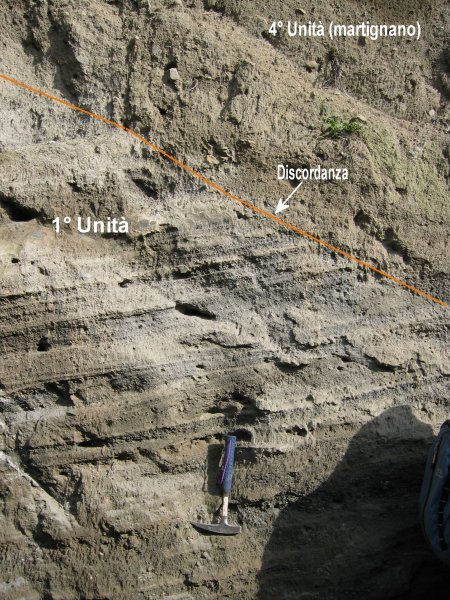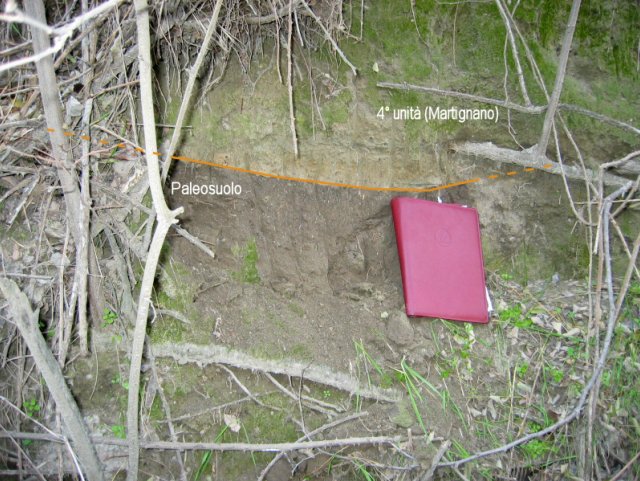Rilevamento
a STRACCIACAPPA

INQUADRAMENTO
GEOGRAFICO
Il centro eruttivo
di Stracciacappa è ubicato nel settore orientale del complesso
vulcanico sabatino, ad Est del lago di Bracciano, nelle immediate vicinanze
del centro eruttivo di Martignano.
INQUADRAMENTO
GEOMORFOLOGICO
Nel Lazio la messa
in posto di lave, piroclastiti di ricaduta e soprattutto di imponenti
colate piroclastiche, connesse ad un’attività altamente
esplosiva, ha originato ampi plateau debolmente digradanti dalle aree
centrali, dove si rinvengono i centri vulcanici principali, verso le
zone periferiche. Il distretto vulcanico alcalino – potassico
dei Monti Sabatini (assieme a quello dei Monti Vulsini), interessato
da una attività di tipo areale, è morfologicamente ampio
e piatto. È caratterizzato dalla presenza di diversi centri vulcanici
sparsi su una vasta area, e nella zona centrale, da una ampia depressione
vulcano – tettonica occupata dal lago di Bracciano. Nei Distretto
vulcanico Sabatino le forme vulcaniche più evidenti sono rappresentate
nel settore orientale dalle depressioni calderiche di Sacrofano e Baccano,
mentre nel settore centro - orientale appaiono molto evidenti morfologicamente
numerosi crateri legati all’attività idromagmatica finale,
come quelli di Martignano e Monterosi, occupati dagli omonimi laghi,
e come quello oggetto del rilevamento: Stracciacappa. Nel settore più
occidentale le principali forme vulcaniche sono rappresentate dai numerosi
coni di scorie e lave che bordano verso N il lago di Bracciano.
INQUADRAMENTO
GEOLOGICO – STRUTTURALE
Il vulcanismo del
Lazio, sviluppatosi a partire dalla fine del Pliocene, è parte
della provincia vulcanica Tosco – Laziale, impostatasi in una
fascia strutturalmente depressa parallela alla costa tirrenica. L’area
è compresa tra il settore più elevato della catena appenninica
e le zone costiere, al margine del bacino del Tirreno. Le rocce vulcaniche
della provincia tosco – laziale possono essere raggruppate in
diverse serie comprendenti rocce da acide a intermedie e rocce potassiche.
Al primo gruppo appartengono termini di natura ibrida tra componenti
di origine crostale e mantellina. Al secondo gruppo appartengono, invece,
rocce ad alto contenuto di K. Nel Lazio il vulcanismo ha originato una
serie di distretti vulcanici a prevalente attività esplosiva
subaerea, che si alternano con strutture ora centrali ora laterali.
Il distretto sabatino è uno di questi.
Il distretto vulcanico sabatino inizia la sua attività più
di 600.000 anni fa, contemporaneamente agli altri distretti alcalino
– potassici del Lazio. Il panorama su cui si edificano i vari
centri esplosivi del distretto è quello di una vasta area pianeggiante
largamente occupata dai sedimenti argilloso – sabbiosi del Plio
– Pleistocene, limitati a occidente dai rilievi sedimentari dei
monti della Tolfa e dai domi acidi dei distretti Tolfa – Ceriti
– Manziana la cui attività era da poco terminata. Verso
oriente la vasta piana era limitata dai rilievi sedimentari meso –
cenozoici del Monte Soratte e, più a S, dei Monti Cornicolani.
Dati i sondaggi profondi effettuati dall’ENEL – AGIP a scopo
geotermico indicano che quasi al centro della piana, poco a SE dell’attuale
conca del Lago di Bracciano, in corrispondenza dell’area di Baccano
– Cesano, era presente una piccola dorsale sedimentaria costituente
un alto morfologico del substrato sedimentario meso – cenozoico
(alto strutturale di Baccano – Cesano). Questa dorsale si trova
attualmente sepolta circa 200m sotto la copertura vulcanica.
L’attività di Stracciacappa, a carattere fortemente esplosivo,
è stata determinata dall’interazione del magma con gli
acquiferi regionali mobilitati in seguito al collasso post – eruttivo
dell’apparato centrale di Sacrofano – Baccano, immediatamente
ad Est. Stracciacappa, infatti, è stato attivo contemporaneamente
a numerosi altri centri durante le ultime fasi esplosive del vulcanismo
sabatino, tra 0.08 e 0.04 m.a. fa.
Il fondo del cratere di Stracciacappa, di forma quasi perfettamente
circolare e con un diametro di circa 0,5 km, è posto circa 30
– 40 m al di sotto del livello medio della campagna circostante.
I prodotti si estendono regolarmente intorno alla conca per una distanza
massima di 1,5 km, ricoprendo un’area di 6 km2. Le migliori esposizioni
sono visibili sul lato nordorientale del cratere (la zona su cui si
è rilevato sono sul lato nordoccidentale del cratere), il cui
orlo appare perfettamente conservato, mentre sul lato meridionale i
depositi risultano mascherati o interstratificati con i prodotti degli
altri centri esplosivi coevi, come ad esempio Martignano. Per la maggior
parte della loro estensione le cineriti di Stracciacappa poggiano sulla
IV unità idromagmatica di Baccano immediatamente a SE e sui prodotti
di Martignano a SW. Nel settore occidentale i depositi delle ultime
fasi esplosive di Stracciacappa sono coperti da altre piroclastiti idromagmatiche
provenienti dai centri di La Conca e Polline.
La sequenza stratigrafica dei prodotti emessi da Stracciacappa presenta
alla base prodotti di ricaduta lapillosi in banconi intercalati a livelli
cineritici sottili. Ai prodotti di ricaduta si intercalano banconi di
prodotti caotici e massivi ricchi in litici. Al di sopra si riconoscono
degli episodi cineritici a stratificazione incrociata e strutture da
impatto intercalati a cineriti grossolane ricche in litici del substrato.
Dopo un piccolo paleosuolo si hanno eventi esplosivi che hanno portato
alla deposizione di cineriti fini ricche in litici caratterizzate anche
da lapilli accrezionari. Il paleosuolo separa due episodi idromagmatici
ben distinguibili: l’episodio sottostante presenta una successione
di livelli ben netta in cui è possibile distinguere bene i livelli
con stratificazione incrociata, quelli massivi e quelli a laminazione
parallela. La granulometria dei livelli cineritici è più
grossolana e non ci sono lapilli accrezionari. L’episodio soprastante
il paleosuolo è molto più caotico, senza distinzioni nette,
vi sono molti lapilli accrezionari e l’ampiezza delle antidune
è molto superiore.
È stato calcolato un volume totale di materiale emesso pari a
circa 0,32 km3; questo è un valore minimo, in quanto il metodo
usato per calcolarlo tiene conto essenzialmente della distribuzione
attuale degli spessori senza tener conto di fenomeni di erosione. Utilizzando
un altro metodo di calcolo si ottiene un valore di 0,78 km3, che può
essere considerato un limite massimo. Sono stati usati anche altri metodi
di calcolo, e alla fine si è giunti alla conclusione che i valori
ottenuti sono confrontabili, permettendo di stimare un volume di materiale
emesso dal cratere di Stracciacappa in media di 0,61 km3, valore che
con buona approssimazione può essere considerato attendibile.
Le analisi granulometriche hanno permesso di distinguere tre gruppi
di sedimenti differenti, sia per modalità di trasporto che di
sedimentazione. Il primo gruppo corrisponde ai sedimenti provenienti
da livelli cineritici a laminazione incrociata, prevalentemente fini.
Il secondo gruppo corrisponde ai sedimenti provenienti sia da livelli
non gradati e non classati che da livelli a laminazione parallela. Il
terzo gruppo comprende sedimenti provenienti dai livelli di fall e flow,
tutti con caratteristiche analoghe, generalmente fini. Sono meglio classati
i campioni idromagmatici rispetto a quelli dei livelli di ricaduta e
di colata piroclastica. A loro volta sono meglio classati i campioni
di colata che quelli di ricaduta. Questo può essere dovuto al
fatto che i livelli di ricaduta della serie stratigrafica di Stracciacappa
rappresentino depositi stromboliani costituiti da lapilli subsferici
debolmente vescicolari in una matrice vetrosa cineritica, come spesso
osservato in vulcani con attività transizionale da stromboliana
a idromagmatica. La presenza d’acqua dovrebbe essere un fattore
determinante per la loro formazione. Probabilmente i livelli di colata
piroclastica rappresentano dei depositi dovuti o al rotolamento delle
piroclastiti sul pendio del cono vulcanico o delle piccole colate piroclastiche
a chiusura di ogni ciclo esplosivo. La presenza ricorrente di livelli
a laminazione parallela alla loro base sembra confermare questa ipotesi.
La maggior parte dei litici è costituita da frammenti lavici
a composizione sia leucititica che fonolitico – tefritica, appartenenti
probabilmente alle colate di lava sottostanti la serie piroclastica
di Stracciacappa, frammenti del substrato sedimentario per lo più
di natura arenacea e frammenti cartonatici. Le particelle vetrose mostrano
composizioni variabili da fonoliti a fonoliti – tefriti. La frazione
cristallina è costituita da cristalli e frammenti cristallini
di leucite, pirosseno, sanidino, plagioclasio calcico e biotite. Il
contenuto in cristalli aumenta notevolmente nelle classi a granulometria
minore e si avvicina allo zero per quelle a granulometria maggiore.
METODO DI RILEVAMENTO
Poiché
si è lavorato esclusivamente nei prodotti vulcanici del centro
eruttivo di Stracciacappa si è usato il metodo di rilevamento
litostratigrafico.
RILEVAMENTO
GEOLOGICO - STRATIGRAFICO
Alla base
della serie eruttiva di Stracciacappa, come si è potuto osservare
da un ottimo taglio dietro una stalla che ha permesso di avere una visione
d’insieme, vi sono i prodotti di quella che si è deciso
di chiamare “prima unità eruttiva” di Stracciacappa.

| Foto
1: un ottimo taglio che permette di avere una visione d'insieme
sui prodotti della Prima Unità eruttiva di Stracciacappa. |
Di tale
unità non possiamo vedere la base, e la prima osservazione che
si può fare alla base del taglio artificiale consiste nella presenza
di un livello scoriaceo di base seguito da una alternanza di strati
cineritici e lapillosi. Uno strato lapilloso tipo ha in media uno spessore
di 50cm e presenta stratificazioni al suo interno L’80% sono clasti
juvenili arrotondati e non vescicolari di 5 – 8 mm di diametro.
I litici sono costituiti da basalto con leucite e pirosseni, tufo piperino,
clasti scuri vescicolari. Rari sono i clasti calcarei. Si trovano comunque
frequenti cristalli di pirosseno, a volte alterati. Procedendo verso
l’alto nell’unità aumentano i litici di dimensioni
maggiori dei lapilli e il contenuto in litici in generale e inoltre
i livelli lapillosi sono più spessi alla base e decrescono di
spessore verso l’alto, mentre aumenta lo spessore dei livelli
cineritici. In un’altra parte del taglio si è potuta osservare
bene una discordanza tra i prodotti della detta prima unità e
i prodotti di un’altra unità, che poi si è deciso
di chiamare “quarta unità” e facente capo al centro
eruttivo di Martignano, che la sovrastano. Il taglio ha anche permesso
di apprezzare la presenza di stratificazioni incrociate all’interno
della prima unità, anche se la stratificazione è prevalentemente
pianoparallela.
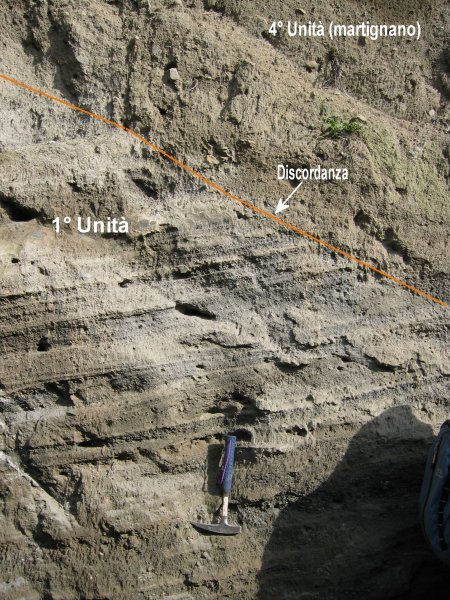
| Foto
2: nel taglio è evidente la giacitura discordante
della Quarta Unità sulla Prima Unità. |
Sopra i
prodotti della prima unità si incontra uno strato di spessore
intorno al metro molto più competente dei depositi sottostanti.
Il materiale componente lo strato è di tipo cineritico, vescicolato.
La maggiore competenza dello strato è dovuta al processo di zeolitizzazione
Si è deciso di porre tale strato al tetto della prima unità,
dato che è seguito da depositi simili a quelli della prima unità,
ma da essi distinguibili. Si è deciso di metterlo al tetto perché
evidenzia la conclusione dell’aumento progressivo in acqua nell’eruzione,
che si evince dai depositi della prima unità.

| Foto
3: sopra i prodotti della Prima Unità si incontra
il livello zeolitizzato, che ne rappresenta il tetto. |
Al di sopra
del livello zeolitizzato si passa ai prodotti della seconda unità.
Sono simili ai prodotti della prima, quindi indice di modalità
eruttive simili, ma aumenta di molto la presenza di litici sedimentari,
anche calcarei, soprattutto in tre livelli principali distinti, e aumentano
in generale le dimensioni e la quantità dei litici lavici. Sempre
nella seconda unità si notano strutture dunari e l’inizio
della presenza di blocchi lavici trasportati di grandi dimensioni, indice
di una notevole densità del flusso. Si trovano anche strutture
da impatto. La stratificazione, a tratti pianoparallela, è però
soprattutto incrociata a basso angolo.
Risalendo ancora nella serie dei prodotti eruttivi di Stracciacappa
si incontra un livello con grandi litici, che può essere preso
come il limite tra la seconda e la terza unità. La sovrastante
terza unità è molto ricca in grandi litici, anche di bombe
di dimensioni ragguardevoli, spesso in matrice cineritica. Sono presenti
dune e strutture da impatto. I blocchi sono spesso trasportati. I livelli
cineritici sono più spessi di quelli lapillosi, il che indica
un deposito tipo surge. La stratificazione è incrociata, ma i
depositi della terza unità perdono in parte una organizzazione
in strati.
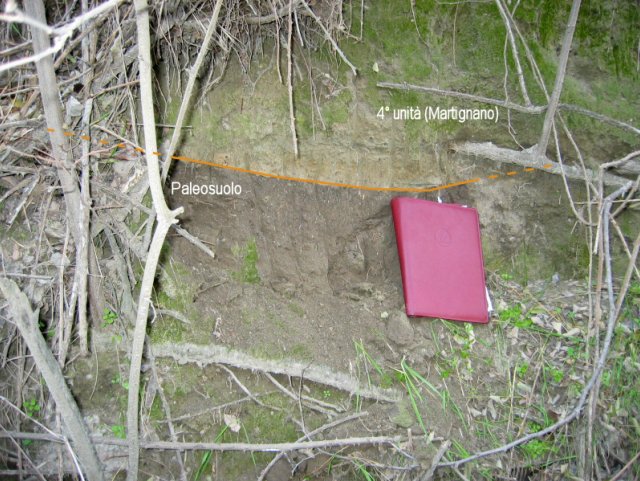
| Foto
4: si nota bene il piccolo paleosuolo sovrastato dai prodotti
della Quarta Unità. |
Procedendo
ancora in alto nella serie si incontra, sopra i depositi della terza
unità, un paleosuolo di spessore decimetrico. Il paleosuolo stesso
è stato preso come limite tra la terza e la quarta unità,
che si trova sopra. Tutti i prodotti che si trovano sotto il paleosuolo
appartengono ad un’unica eruzione. I depositi soprastanti invece
sono ascrivibili alla quarta unità, già osservata peraltro
nel primo stop in discordanza rispetto alla prima unità. Qui
questi depositi sono in contropendenza rispetto a quella osservata al
primo stop. Sono cineriti fini ricche in litici caratterizzate da una
organizzazione molto più caotica, senza distinzioni nette. Vi
sono molti lapilli accrezionari, inclusi sienitici e l’ampiezza
delle antidune è molto superiore. Questa quarta unità,
come già detto, è del centro eruttivo di Martignano.
Successivamente si sono percorse altre due strade che scendendo verso
il fondo del cratere hanno permesso l’osservazione delle tre unità
descritte sopra. Queste si presentano similmente alla prima strada,
con piccole differenze. Nella seconda strada lo spessore dello strato
zeolitizzato preso come limite tra la prima e la seconda unità
è maggiore. Nella terza unità inoltre si notano evidenti
strutture da flusso. Nella terza strada, ancora nella terza unità
vi sono numerosi grandi blocchi trasportati. Ancora nella terza strada,
infine, si può osservare una lente di prodotti della quarta unità
(Martignano) isolata sui prodotti della terza unità.
OSSERVAZIONI
RELATIVE AL RILEVAMENTO GEOLOGICO – STRATIGRAFICO
·
L’alternanza di strati cineritici e lapillosi caratteristica della
prima unità suggerisce una attività pulsante di Stracciacappa,
dovuta probabilmente all’interazione con una falda.
· Sempre nella prima unità, la presenza di cristalli è
indice di un certo gradi di cristallizzazione nella camera magmatica.
· Ancora nella stessa unità l’andamento dei depositi,
che evidenzia verso l’alto un aumento dei litici di dimensioni
maggiori dei lapilli e del contenuto in litici in generale e inoltre
il maggiore spessore dei livelli cineritici, suggerisce una iniziale
minore interazione acqua – magma, interazione che via via aumenta
salendo nel deposito.
· Il processo di zeolitizzazione, che rende così particolare
lo strato al tetto della prima unità, salda il deposito in caso
di un eccesso di acqua nella nuvola eruttiva e quindi è dovuto
ad una forte interazione del vetro con l’acqua.
· La maggiore presenza di litici sedimentari nella seconda unità
è indice di un approfondimento del livello dell’eruzione,
che va ad interessare anche le litologie carbonatiche site in profondità
sotto l’apparato.
· La presenza di grossi litici trasportati nella terza unità
è indice di un forte aumento della densità del flusso.
· Il fatto che, ancora nella terza unità, i depositi perdano
in parte una organizzazione in strati, è riconducibile alla presenza
d’acqua in gran quantità, con sovrapposizione delle pulsazioni
dell’eruzione e ulteriore approfondimento del livello eruttivo.
· Il paleosuolo che si trova sopra la terza unità è
indice di una stasi nell’attività.
· La presenza della lente di prodotti della quarta unità
(Martignano) isolata sui prodotti della terza unità testimonia
il fatto che la quarta unità si è deposta sopra le unità
di Stracciacappa, coprendole completamente.
CONCLUSIONI
Stracciacappa
rappresenta un esempio tipico di tuff ring la cui attività idromagmatica
“dry” si è trasformata in “wet” nelle
ultime fasi del suo ciclo esplosivo. La distribuzione delle isopache
dei suoi prodotti e i relativi volumi calcolati testimoniano la sua
limitata capacità esplosiva. I depositi suggeriscono un rapido
raffreddamento del magma prima della sua essoluzione a giorno. Ad una
prima fase di attività a bassa energia con livelli di ricaduta
e piccole colate piroclastiche segue una fase con maggiore energia esplosiva
testimoniata dai primi livelli a stratificazione incrociata. Dopo una
breve stasi l’attività riprende con ancora maggiore esplosività.
Gli ultimi episodi esplosivi idromagmatici presentano infatti un grado
di frammentazione maggiore e un più alto contenuto in litici,
anche del substrato carbonatico. Quest’ultimo dato si può
spiegare sia con una maggiore interazione magma – acqua, sia,
più probabilmente, con un approfondimento del livello esplosivo,
ipotesi confermata dall’aumento dei litici carbonatici appartenenti
alla parte più profonda della serie sedimentaria sottostante
nei livelli più alti della serie stratigrafica di Stracciacappa.
La natura dei terreni al di sotto delle vulcaniti e il loro assetto
strutturale in questo settore sembra suggerire che l’attività
di Stracciacappa sia legata all’interazione di un magma profondo
che risaliva lungo fratture a carattere regionale con acquiferi di limitata
portata, contenuti nelle unità flyschoidi. Dopo un breve stato
di quiescenza evidenziato dal paleosuolo i prodotti di Stracciacappa
sono stati coperti dai prodotti del vicino centro eruttivo di Martignano,
identificabili con la quarta unità.
BIBLIOGRAFIA
D. DE RITA,
G. ZANETTI – Caratteri vulcanologici e deposizionali delle piroclastici
di Stracciacappa. Mem. Soc. Geol. It., v. 35, 1986.
SOCIETA’ GEOLOGICA ITALIANA – Guida geologiche regionali
– Lazio. Be-Ma editrice.
TORNA
A HOME
TORNA
A LEZIONI DI GEOLOGIA
|